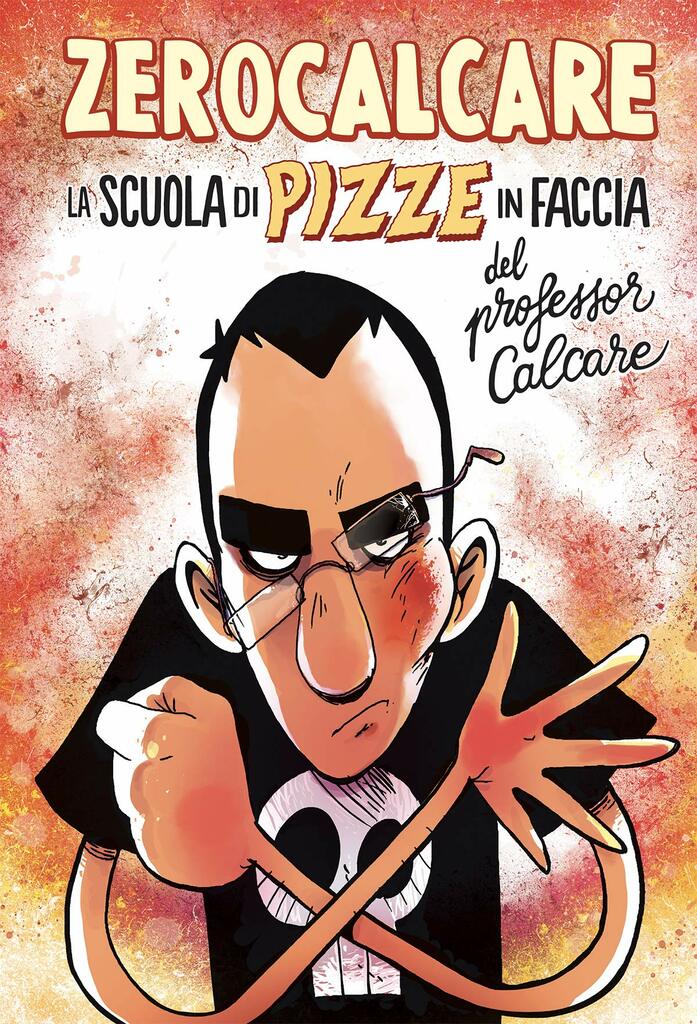Stando ai dati resi noti dall’Osservatorio dell’AIE (Associazione Italiana Editori) per il 2024, oltre al persistere di una spaccatura tra Nord e Sud, la qualità della lettura in Italia sarebbe in netto peggioramento.
«I dati sulla flessione dei tempi di lettura e del numero di lettori, che vanno di pari passo alla flessione del mercato, confermano la necessità di tornare a sostenere la domanda di libri nel nostro Paese soprattutto tra i più giovani, creando una consuetudine con i libri che prosegua nel corso di tutta la vita», ha detto il presidente dell’AIE, Innocenzo Cipolletta, intervenendo all’incontro “La lettura debole. Pochi lettori o letture troppo brevi?”, tenutosi alla Fiera nazionale della piccola e media editoria di Roma, “Più libri più liberi”, nel dicembre scorso.
Tornare a sostenere la domanda di libri nel nostro Paese… Mi pare un obiettivo tanto condivisibile quanto fantascientifico, perché basterebbe entrare in una scuola superiore di II grado, un professionale per esempio, passarci almeno una settimana, per capire il livello di preparazione e, peggio, di disinteresse nei confronti della “cultura” della maggior parte degli studenti e, purtroppo, anche di qualche insegnante. Altro che libri e lettura!
La scuola è dove si formano o dovrebbero formarsi le nuove generazioni, benché su che cosa si intenda per “formazione” pare difficile intendersi.
Prendiamo uno studente di informatica. È sicuramente auspicabile che al termine del suo ciclo di studi abbia acquisito le competenze necessarie ad affacciarsi e successivamente entrare nel mondo del lavoro. Ma la scuola ha solo questo compito?
L’ignoranza su come funzioni il nostro Stato, sulla storia, in relazione alla geo-politica del mondo contemporaneo; sui temi ambientali; l’uso di un vocabolario ridotto ai minimi termini; l’incapacità di gestire le emozioni; finanche l’educazione… io a scuola assisto tutti i giorni a una Caporetto. Ma da dove arriva questa disfatta? Evidentemente non in tutte le scuole la situazione è tale, ma nei “professionali” mi sento di affermare che lo sia, non solo in base alla mia esperienza, ma in base anche all’esperienza di altri insegnanti ed educatori con cui mi confronto e che operano in questi ambiti. In certe zone, in certe periferie del Nord, si comincia addirittura a respirare un’aria difficile già nelle scuole secondarie di I grado. Ci sono adolescenti che a 12, 13, 14 anni manifestano malesseri e aggressività che gli insegnanti e gli educatori fanno molta fatica a gestire e che poi arrivano, allo step successivo delle superiori, a livelli di guardia.
Mi viene da ridere quando sento la gente comune dire: «questo dovrebbero insegnarlo a scuola», «sarebbe compito della scuola…», «ma che cosa gli insegnano a scuola?»… e via discorrendo, come se la scuola fosse il “luogo” dove tutto si può fare e dovrebbe essere fatto. La scuola viene tirata di qua e di là, a seconda delle proprie convinzioni ideologiche, dei propri interessi (non scordiamoci la scuola-azienda), della propria coda di paglia.
C’entra il Ministero della Cultura e del Merito? C’entrano gli insegnanti? C’entrano i genitori? C’entra la tecnologia con la pervasività dei suoi device? C’entra la mancanza di finanziamenti all’istruzione? C’entra la totale o quasi totale mancanza di politiche di integrazione e inclusione adeguate? C’entra…? C’entra tutto. Perché la scuola è lo specchio della società, lo specchio di quello che siamo.
Qualche volta vorrei che nelle aule ci fossero delle telecamere, perché quello che accade quotidianamente in quelle stanze quasi sempre trascurate, quasi sempre inospitali, rischia di non essere creduto.
Che sia proprio la mancanza di “bellezza” a rendere così brutto restare chiusi lì dentro per sei ore al giorno? Nel guardarmi attorno, camminando per strada, sui mezzi pubblici, riscontro tuttavia mancanza di bellezza e cura ovunque. Non sono solo i ragazzi a sporcare, a non prendersi cura di ciò che abitano, sia esso l’ambiente o le relazioni, a vagare senza punti di riferimento, ho l’impressione che si sia diventati un po’ tutti schiavi – è il caso di dirlo – di modi di vivere che con la bellezza e l’empatia umana hanno poco a che spartire: contano i soldi, l’apparire, la bella vita.
Vediamo qualche dato.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rende noto che per l’anno in corso il totale dei frequentanti un istituto superiore di II grado (dal 1° al 5° anno) è di 2.619.287 ragazzi, così suddivisi:
51,4% Licei;
31,8% Tecnici;
16,8% Professionali.
A questo computo totale devono essere aggiunti gli studenti iscritti alle scuole di II grado paritarie: 132.284 (il 13,9% del totale relativo agli iscritti alle paritarie per l’anno scolastico 2023/24) – il primato è della Lombardia con 36.664 unità. In merito a queste cifre non troviamo indicate, però, le percentuali relative al tipo di scuole superiori scelto.
Esistono, inoltre, gli operatori per i servizi di istruzione e formazione professionale accreditati dalle regioni. L’Albo regionale lombardo – la regione dove risiedo –, aggiornato al 14/03/2025, ne elenca ben 1481.
Dando un’occhiata ai dati inerenti alle scuole della provincia di Lodi pubblicati nel novembre scorso dalla Fondazione Agnelli (edizione 2024/2025 di Eduscopio), salta subito agli occhi che a fronte di un primato del Liceo Classico “Giovanni Gandini” (Lodi) con l’indice FGA più alto (84,79/100) – l’acronimo FGA si riferisce a un indicatore sintetico che tiene conto, al contempo, della media e della percentuale di crediti conseguiti – la frazione in percentuale dei diplomati degli istituti professionali che hanno raggiunto il traguardo del diploma senza bocciature si abbassa in modo drastico: siamo sotto il 50% che arriva, per alcune scuole, a una percentuale del 20,10%. Bocciature a parte, non sono pochi i ragazzi che decidono di piantare il percorso di studi anzitempo.
Dove vanno a finire? Troveranno un lavoro e, nel caso, che tipo di forza lavoro saranno? Che tipo di cittadini saranno? Quale società costruiranno?
Lettura e libri: rieccoci a bomba. Date le premesse, è davvero realistico pensare di tornare a sostenere la domanda di libri a partire dalle scuole coinvolgendo, e la butto lì, studenti di istituti professionali e tecnici, i più lontani dalla consuetudine alla lettura, e quindi probabilmente i più esposti alla manipolazione, nonché al precariato e allo sfruttamento nel mondo del lavoro? Bastano le belle parole spese nelle tavole rotonde e nei talk show o non occorrerebbe, invece, riflettere senza ipocrisia sul tipo di società e di valori che abbiamo apparecchiato per questi ragazzi? A chi fa comodo contare su cittadini-forza lavoro sottopagati e ignoranti?
P.S. Cover: https://www.deviantart.com/il-signor-m/art/Storia-di-uno-studente-cerco-lavoro-362024737